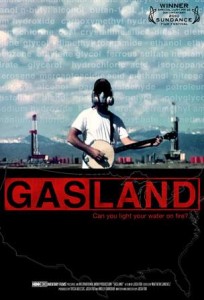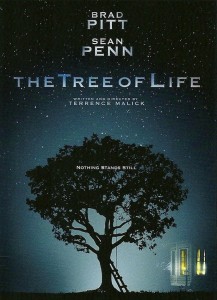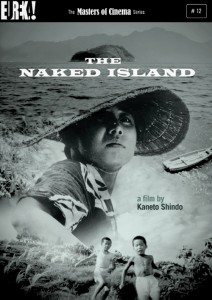Posted: June 1st, 2011 | Author: anarcosurr | Filed under: L'age d'or | Comments Off on Gasland
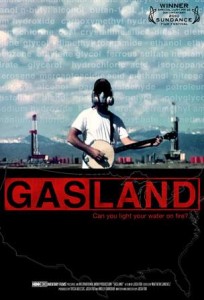
Da voi l’acqua prende fuoco?
Questa è la catch-phrase del documentario Gasland di Josh Fox, che denuncia i rischi del “fracking”, una tecnica usata per l’estrazione di gas naturale che prevede l’iniezione nel terreno di migliaia di litri di acqua contenente sostanze tossiche e metalli pesanti. Acqua che viene recuperata solo in parte e che si mescola inevitabilmente alle falde acquifere, contaminando l’acqua potabile e compromettendo l’equilibrio ambientale. Nei luoghi più vicini agli impianti di estrazione, l’acqua del rubinetto prende fuoco, gli animali muoiono e le persone si ammalano: nei casi meno gravi, mal di testa e piccoli disturbi inspiegabili, nei casi più gravi perdita del gusto, cancro e neuropatie degenerative.
I pozzi sono stati costruiti senza rispettare le norme più elementari contro l’inquinamento idrico, cancellate dall’amministrazione Bush nel 2005 – una deregolazione che ha reso il settore del gas naturale negli States economicamente lucrativo e di fatto ha aperto una vera e propria corsa speculativa, con centinaia di migliaia di pozzi aperti in 6 anni e almeno altrettanti in progettazione.
La nocività del fracking è difficilmente dimostrabile, perché le compagnie non sono obbligate a rendere pubblici gli agenti chimici che vengono aggiunti al liquido di frattura. E, in ogni caso, le corporations procedono secondo una linea di disingaggio ormai collaudata: acquistano la protezione dall’alto, negano ogni responsabilità, isolano le singole vittime proponendo accordi privati, se gli va male patteggiano i danni, e poi vanno da qualche altra parte. Per ogni Erin Brockovich, migliaia se lo prendono nel culo.
Sul sito del film, interessante per il modo in cui cerca di coordinare iniziative spontanee in tutti gli Stati Uniti, c’è uno schema in flash che spiega in dettaglio cos’è il fracking:
what-the-frack!
Fox è un emulo di Moore, ma più magro e sofisticato e inserito nei circuiti artistici della Grande Mela. Flint da una parte, New York dall’altra. Inutile dire che la mia preferenza va alla prima. Comunque, anche se Fox è meno pantagruelico di Moore, resta comunque un americano “folk”, il che comporta:
1- un’affinità innata per il banjo e le maschere antigas (quello nella locandina è lui)
2- un istinto irrefrenabile che, di fronte a una qualunque cosa chiaramente stupida e visibilmente pericolosa, spinge gli americani a provarla sulla propria persona

Gasland bilancia bene interviste (preponderanti, ma riprese in mezzo alle baracche e alle campagne sporche del Midwest come si vedono solo nei film di Debra Granik), schede tecniche (dinamiche, alla Food Inc. e The Corporation, ma meno ricche e inventive) e momenti puramente cinematografici, che sono quelli artisticamente migliori – nevi sgranate, strade e deserti industriali.
Il documentario centra l’estensione del problema, ma manca la bigger picture, che si limita ad un salviamo la terra degli uomini liberi, senza un discorso politico complessivo – un mix di ecologia, democrazia partecipativa e radici americane che è evidentemente debitore di una cultura politica radicale, ma da cui allo stesso tempo prende un po’ le distanze, anche solo per non spaventare la fetta di americani più conservatori, ma comunque colpiti dalla trivellazione del gas.
Per un motivo coerente e analogo, il film insiste sull’imminente cessione alle principali compagnie di estrazione dei terreni pubblici del bacino del fiume Delaware, che fornisce l’acqua potabile di New York e Philadelphia. Come dire, tra poco il laghetto coi cigni di Central Park diventa una vasca di trementina. In questo modo Fox va a colpire nell’intimo i circoli dell’élite, che hanno, a livello politico e mediatico, un peso almeno pari a quello di tutto il resto del paese.
Sarà interessante valutare l’impatto di Gasland, specialmente perché, come e forse più di altri documentari contemporanei, non è soltanto l’interpretazione di un fatto finito, ma è concretamente mirato ad ottenere effetti politici a breve-medio termine.
E anche perché, molto presto, le compagnie di gas metteranno gli occhi sull’Europa.
Carlo
Posted: May 24th, 2011 | Author: anarcosurr | Filed under: L'age d'or | Comments Off on Cut the tree of life
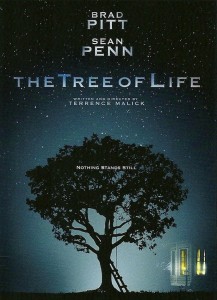
Fotografia impareggiabile, inesorabili moti celesti, amniotici paesaggi sottomarini e alghe Tarkovskiane, la digressione più lunga della storia del cinema e lo stormo di uccelli più suggestivo, un coelophysis pietoso e Brad Pitt nel difficile ruolo del Nome del Padre, risolto brillantemente con culo squadrato e mascella fissa, l’ultima scena sulla spiaggia che fa rimpiangere il finale di Longtime Companion – più semplice, più umano.
Due ore e rotte di estasi panteista che non mi sono piaciute per niente, nonostante i più onesti sforzi. L’impressione è che la giuria di Cannes abbia scambiato, come succede, la grandezza del tema per l’efficacia della realizzazione: se The Thin Red Line aveva un limite entro il quale la tecnica e l’atmosfera rarefatta del regista andavano a segnare un punto per la pace e la fratellanza universale, The Tree of Life si perde oltre l’orizzonte.
L’indifferenza di dio e l’ineluttabile ingiustizia fra gli uomini, che il film rappresenta attraverso il mito di Caino, nella versione di Saramago, non regge però il confronto con la profondità, il cinismo e la piacevolezza dello scrittore portoghese. Tanti sono i punti in comune tra il film e il romanzo, tanti quelli in cui il film sfigura.
La suggestione più interessante che il film permette è quella di un dio dai tre volti, maschile, impersonale e femminile, che potrebbe tentare una critica psicanalitica di indirizzo femminista e post-lacaniano (tipo Luce Irigaray e Cornelius Castoriadis, tanto per confermare che Malick resta un texano culturalmente ben pasciuto). Il momento più consapevole in questa direzione sembra essere quando il giovane Caino si rende conto che la sua ribellione contro il Padre non fa altro che renderlo uguale a lui, e che l’alternativa è una religiosità più aperta e più femminile.
Ma pur sempre passiva, e pur sempre religione.
Carlo
Posted: April 28th, 2011 | Author: anarcosurr | Filed under: L'age d'or | Comments Off on Gaza-strophe

Ottimo documentario di Samir Abdallah et Khéridine Mabrouk sull’operazione Piombo Fuso contro la popolazione di Gaza.
Il link è a una versione ridotta di 50m, contro l’ora e mezza dell’originale cinematografico.
Non ha bisogno di commento.
Posted: April 26th, 2011 | Author: anarcosurr | Filed under: L'age d'or | Comments Off on God-soldier

Con Caterpillar, a settanta e rotti anni e dopo una vita di soft-porn e pulp giapponese, Koji Wakamatsu firma un autentico film militante, con tutti i pregi e i difetti che potrebbero essere quelli di un giovane regista di cinquanta anni fa.
Storia minima: seconda guerra mondiale, fronte cinese, il soldato giapponese Tadashi perde braccia e gambe e rimane sfigurato mentre stupra una donna. Spacciato dall’esercito per un eroe di guerra, torna a casa pieno di medaglie e elevato al rango di soldato-dio. Orribile, incapace di parlare, non più umano, Tadashi è il soldato modello, l’orgoglio del suo paese, un feticcio dell’autorità nazionalista. Per questo deve restare in vita anche se non può più avere una vita, e per questo la sua giovane moglie Shigeko è costretta ad occuparsi di lui pulendolo, nutrendolo e soddisfando i suoi non sopiti istinti sessuali. Già prima della guerra un marito violento, da mutilato il soldato-dio diventa un dio-bambino esigente, egoista e, se possibile, ancora più oppressivo.
Sottomessa al marito e allo stato, Shigeko deve conservare le apparenze impeccabili della moglie di un martire, ogni giorno subendo nel suo intimo l’orrore della guerra. Prova a ribellarsi, ma non può farlo fino in fondo. Infine, all’apice della violenza, con la sconfitta del Giappone e all’alba del terrore atomico americano, il soldato-dio si suicida annegandosi in uno stagno. Non prima di aver sofferto come un cane per tutto il film e disgustato in ogni modo gli spettatori.

Caterpillar è un film diretto, povero e rivoltante.
A livello formale è troppo sciatto per essere un film “orientale” e ugualmente non abbastanza sgranato e sobbalzante per passare per una prova di Dogma. Sembra una soap opera antifascista, e il contrasto tra la forma e il tema avrebbe potuto essere efficace.
Purtroppo, lo stile finisce per sostenere l’aspetto didascalico del film, che Wakamatsu rinforza oltre misura riducendo la trama a una mezza dozzina di scene ripetute ossessivamente: cibo, violenza, sesso, escrementi e medaglie…
Il lato migliore, invece, è l’antifascismo schietto, marcato e offensivo – offensivo per i fascisti e per il buongusto borghese. In uno dei passaggi più raffinati, al contrario, l’occhio della ragazza cinese stuprata, invaso dalle fiamme di un incendio, diventa il sole nascente della bandiera nipponica. Provate a immaginare qualcosa di simile con un repubblichino.
Anche se Wakamatsu non attacca il fascismo nelle sue forme più contemporanee, nell’organizzazione del lavoro, nel consumo, nella violenza verso i migranti, sputa comunque in faccia al nazionalismo e denuncia, senza facili illusioni di riscatto, l’oppressione della donna.
Quanti giovani registi, in questo, sono molto più vecchi di lui.
Carlo
Posted: April 16th, 2011 | Author: anarcosurr | Filed under: L'age d'or | Comments Off on Some day your prince will come

Pluripremiato da pubblico e critica, artisticamente e politicamente engagé, Wasteland (Lixo Extraordinário) è un documentario, frutto della collaborazione tra l’artista Brasiliano Vik Muniz e la documentarista Lucy Walker, che tratta del riscatto di una comunità attraverso l’arte e del riscatto dell’arte attraverso il suo contatto con la società.
Wasteland ha una grande potenza ideologica e in più il progetto artistico e sociale di Muniz che il film documenta ha un dichiarato e non banale intento politico. Le due cose insieme ne fanno un lavoro eccezionalmente raro, da cui la valanga di premi.
Purtroppo, alle grandi promesse del tema e alla forza dei simboli corrisponde un risultato politico deludente. Potremmo tagliare corto e buttarla sul personale, criticando Muniz per aver sfruttato l’iniziativa quasi esclusivamente a suo vantaggio. Ma sarebbe riduttivo, e invece Wasteland è un film da vedere e su cui discutere.
Anche perché è facile che venga preso come un esempio di arte illuminata o anche solo come un testimonial di campagne ecologiste. Il danno che farebbe in questo caso è di rinforzare una partecipazione distante, virtuale, nella gestione dei problemi comuni, e questo nonostante il fatto che Muniz sia, o sembri, molto più concretamente presente di altri artisti.
Ma andiamo con ordine.
Il documentario mostra alcuni “catadores”, raccoglitori di rifiuti, che lavorano in una gigantesca discarica a cielo aperto tra le favelas di Rio, eufemisticamente chiamata Jardim Gramacho. I catadores fanno la raccolta differenziata al posto di chi la dovrebbe fare: la fanno nella discarica, dove i rifiuti di tutti i tipi arrivano già mischiati, raccogliendo, pezzo per pezzo, vetro, pvc, plastica, carta, metallo.
Trailer.
Muniz, l’artista, lavora anche lui con i materiali. Comincia scattando una fotografia, di solito un ritratto. Poi la riproduce, ingrandita, in modo da ricoprire con l’immagine tutto il pavimento di un magazzino. A quel punto, riempie la figura sul pavimento con una texture di materiali e oggetti di ogni tipo. Una volta riempita la figura in questo modo, fotografa il risultato e questa foto, ridotta alla dimensione di un quadro, è l’opera finita. A parte la necessità di spazio e di una strumentazione fotografica particolare, è un procedimento più semplice di quanto non sembri a descriverlo a parole.


All’aspetto tecnico della sua arte, poi, Muniz ha da sempre associato una particolare risonanza ideologica. I materiali con cui ricostruisce i suoi ritratti sono gli stessi materiali con cui le persone ritratte sono a contatto quotidianamente: un contatto che spesso prende la forma di oppressione. Per esempio,una delle sue prime serie di opere di successo (Sugar children, 1996) riproduceva le foto di alcuni bambini usando lo zucchero delle piantagione in cui loro, come i loro genitori, sarebbero stati costretti a lavorare tutta la vita.

Oltre a questo, Muniz tende a rinforzare la dimensione ideologica delle sue opere componendo i ritratti di partenza secondo una iconografia da pop-art.

Nella serie di opere realizzate al Jardim Gramacho, in particolare, la costruzione artificiosa dei soggetti ne rinforza la potenza simbolica, ma in modo così retorico da risultare estraneo alla materia sociale di cui tratta. Il gioco è chiaramente quello di creare un contrasto, ma a che scopo?

L’intenzione di Muniz è di migliorare le condizioni di vita dei catadores. Materialmente, dandogli un lavoro migliore, come assistenti nella realizzazione delle sue opere e offrendogli una parte del ricavato della loro vendita. Meno materialmente, proponendo loro una esperienza che rinforzi la stima in loro stessi, ne apra gli orizzonti mentali e dunque li metta in condizione di reagire e migliorare la loro condizione con le proprie forze.
Il discorso suona bene, ma dimentica un paio di cose. Prima di tutto, che non si può bypassare la pratica politica vera e propria.
Muniz, come molti altri, distingue la pratica artistica engagé dalla pratica politica. Lascia che sia Tiao, un ragazzo che ha fondato il primo nucleo della cooperativa dei catadores di Jardim Gramacho, ad occuparsi delle rivendicazioni sindacali dei lavoratori della discarica. Muniz si limita a dargli un’occasione in più per portare avanti il suo lavoro e in questo, almeno in parte, evita l’ipocrisia.
Ai catadores Muniz non promette nessun riscatto collettivo. Ne prende alcuni, li mette a lavorare, gli fa fare una bella esperienza e gli dà un po’ di soldi. Tutto qui. Onestamente, Muniz non pretende di più, non si mette a fare il profeta della rivoluzione, né l’organizzatore politico, perché non ne sarebbe capace e perché, in effetti, il suo mestiere è un altro.
Ma questo è il massimo livello di onestà che il progetto riesce ad ottenere. Muniz riconosce i suoi limiti come artista: l’arte non può fare di più, il resto è politica.
E tuttavia, questo limite è fondamentale. La politica, in senso lato, non può essere ridotta ad un oggetto dell’arte, perché è una sua dimensione. Tutta l’arte è politica, dunque non importa quanto un’opera sia più o meno dichiaratamente politica, ma quanto sia politicamente efficace.
E il progetto di Muniz, in questo senso, si dice politico, ma non lo è. Specialmente perché evita con cura ogni forma di critica.
Muniz sfrutta abilmente il suo tema sociale, facendo risuonare tutte le sue associazioni simboliche e incorporandolo nella sua visione dell’arte, sfrutta la situazione dei catadores come un serbatoio di metafore e come il collegamento tra arte e realtà, che è necessario per un’opera d’arte impegnata.
Nel fare questo, non tocca nemmeno per sbaglio un tasto sgradevole ai ricchi potenziali compratori delle sue opere.
L’intero progetto di Wasteland si basa, a livello del discorso, su una serie di strutture ideologiche forti, ma convenzionali: rifiuti – rifiuti umani, riciclaggio – arte, artista – rivoluzionario. In questo modo Muniz vende le sue foto e in questo senso le sue foto non sono rivoluzionarie. Il film si autodefinisce una storia di moderne cenerentole, alla faccia dell’impegno sociale!
La foto di Valter, un vecchio operaio in tutti i sensi, impermeabile all’arte di Muniz, è messa in fondo al film, ma non entra nell’esposizione.

In definitiva il film rinforza idee di successo personale nei catadores come negli spettatori e promuove un individualismo “fatale” – nel senso di casuale e di mortale: fai la tua (ingiusta) parte, non ribellarti, e forse un giorno arriverà il tuo principe azzurro.
Carlo
Posted: March 23rd, 2011 | Author: anarcosurr | Filed under: L'age d'or | Comments Off on Welcome to the island of the real
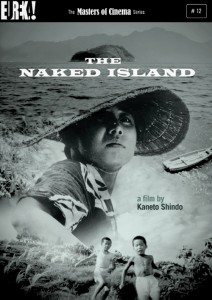
The Naked Island (1960) di Kaneto Shindo non è un film allegro, né leggero. Per un’ora e mezza, senza un’ombra di dialogo, vediamo una donna e un uomo raccogliere acqua lungo un fiume e portarla in barca sull’isola dove vivono per irrigare qualche misero pezzo di terra arrampicato sulle alture. Li vediamo ignorare amorevolmente i loro figli piccoli che faticano quanto loro, sorridere, appena, quando uno dei bambini pesca un pesce che possono vendere al mercato e finalmente piangere, e poi ricominciare da capo, quando il figlio maggiore muore.
Se questa storia spaccacuore e senza scampo merita ancora di essere riproposta nei cinema d’essai è per via della chiara denuncia che fa della condizione femminile, nel Giappone dell’epoca, e perchè evoca allo stesso tempo i due volti della fatica – quello fascista del sacrificio e quello operaio della dignità e della resistenza attraverso il lavoro. E in questo è reale e, riflettendoci in un secondo momento, meno retorico dell’apparenza e, probabilmente, delle sue intenzioni.
L’isola nuda, l’isola senz’acqua che la famiglia coltiva per conto di un padrone silenzioso e distante è definita innanzitutto come il luogo limite dello sviluppo: “coltivare sempre di più, coltivare sempre più in alto”, in luoghi sempre meno umanamente accessibili. Uno sviluppo che era sostenibile allora come oggi solo perché sorretto dalla fatica allucinante dei contadini. Per noi, occidentali e borghesi, questa fatica oggi come in passato ha sempre parlato un’altra lingua – il dialetto, l’arabo, il cinese.
Poi, nei deliranti minuti dedicati ai viaggi avanti e indietro sulla barca, su e giù per la montagna, tutto per portare quattro secchi d’acqua al campo, il film vira sul metafisico. Dal soggetto politico della fatica contadina all’universale frustrazione di fronte alla realtà che, zizekianamente, è deserto del reale. Qui sta la dignità della famiglia di contadini. Loro creano, fanno crescere. E tuttavia la loro lotta, nobile, contro la loro condizione corrisponde nell’orizzonte chiuso dell’oppressione alla riproduzione del sistema che li opprime.

Il film distingue tra la sofferenza della donna e il silenzio dell’uomo, che la picchia quando è troppo stanca per lavorare e che continua a coltivare in silenzio, oltre il dolore e senza il minimo accenno di rivolta. E qui il discorso è critico (nel denunciare la famiglia patriarcale giapponese) e convenzionale allo stesso tempo (nell’assegnare ruoli fissi all’uomo e alla donna). Pure, questi ruoli fissi fanno parte dell’oppressione che i contadini subiscono e, in fondo, essi stessi non conoscono altri modi di subire le loro disgrazie.
In definitiva, The Naked Island è un film che ti fa venire voglia, appena uscito dal cinema, di andare a vedere Rango. Il che la dice lunga su quanto ci piaccia stare lontano dalla realtà.
Carlo