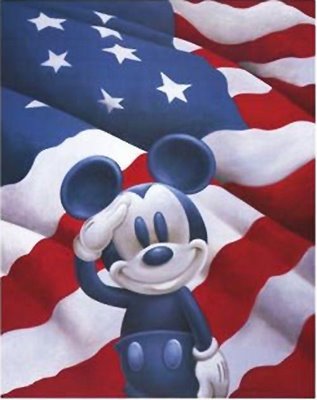Posted: March 3rd, 2011 | Author: anarcosurr | Filed under: La Sortie de l'école | 2 Comments »

Gli indios Boroboro del Sud America avevano, a modo loro, risolto definitivamente ogni problema di identità: sapevano di essere allo stesso tempo esseri umani e pappagalli di una specie rosso fiammante. La loro era, nelle parole di Eisenstein, una identità sincrona.
Eisenstein usò questo aneddoto per descrivere il lavoro dell’attore ad una conferenza ufficiale dei Lavoratori del Cinema Sovietici nel 1935, che, tra l’altro, lo stava mettendo alla gogna per la sua scappatella di sei anni in Europa, Stati Uniti e Messico, finita nel ’32, e per la sua recente improduttività di artista di regime. Immaginatevi la scena.
Ricamando sulle teorie di Meyerhold con la sua idea di montaggio, Eisenstein riteneva che l’identità del personaggio (che poi è l’identità dell’attore col personaggio) si costruisse attraverso la combinazione di elementi eterogenei – emozioni, gesti, ricordi, pensieri, pezzi di scenografia eccetera. Dai suoi primi articoli sul cinema non ha cambiato idea: l’arte è montaggio e il montaggio è conflitto – una trasformazione in “immagini” del principio dialettico.
Eisenstein sembra insinuare che i Boroboro vivono la dialettica materialista più degli artisti organici e dei commissari di partito. E infatti, con questi ultimi, non ha avuto molta fortuna.

Se l’idea di indentità che suggeriscono Eisenstein e i Boroboro è sincrona, allora sono post-moderni pure loro? No. Però è interessante che il loro modo di costruire l’identità sia all’opposto di quello del rivoluzionario contemporaneo, che, invece, tendenzialmente si basa sul rifiuto di ideologie dominanti. Cioè, su un processo di identificazione al contrario.
Molto meglio sarebbe non avere affatto una identità di rivoluzionario. Anzi, visto che l’identità, rivoluzionaria o meno, altro non è che identificazione, una delle forme base della rinuncia alla libertà e all’autonomia, meglio ancora sarebbe non avere proprio nessuna identità.
Di nuovo i post-moderni.
Ma come si fa a non negoziare una identità in un sistema elastico, che tende a includere ogni deviazione?

No idea.
Però una cosa si può dire. Mentre l’identità viene soprattutto definita in relazione alla produzione (cosa faccio), ora, nei discorsi, l’accento sembra essersi spostato più che altro sul consumo (cosa compro).
Ma è solo una impressione, ovviamente: sempre di produzione si tratta.
Abbiamo l’impressione che il consumo sia fondamentale nella determinazione della nostra identità solo nella misura in cui abbiamo perso il contatto con la produzione e con lo sfruttamento reali. Produzione e sfruttamento che “esternalizziamo” continuamente, con la complicità dei media, oltre i nostri confini, nazionali e privati.
In questo scenario non è facile riconoscere che attraverso il consumo (non importa se di prodotti dominanti o alternativi) non acquistiamo nessun pezzo di identità. Non solo può essere sbagliato in senso sociale, ma non funziona neanche a livello personale.
Politicamente, il punto non è tanto che siamo passivamente assorbiti in una struttura ideologica, ma il fatto che diamo attivamente il nostro assenso ad un modello di produzione.

Prendiamo questo esempio dal documentario Food, Inc. di Robert Kenner e Elise Pearlstein. Ogni volta che scegliamo un prodotto è come se stessimo facendo un referendum democratico sulla produzione. Vero. Di conseguenza, con azioni organizzate, si può arrivare a piegare colossi come WallMart a adottare prodotti ecosostenibili. Vero anche questo.
Quello che non funziona in questa tesi è che WallMart resta in piedi. In una versione moderna del paradosso della nave di Teseo, anche se centinaia di campagne forzassero WallMart a sostituire tutti i suoi prodotti e se alla fine arrivasse a vendere solo prodotti ecosostenibili, WallMart avrebbe sempre lo stesso potere di monopolio – a livello delle relazioni di produzione, sarebbe esattemente identico a com’era prima.
Generalizzando, ma ci sarebbe altro da dire, ogni azione a livello della sovrastruttura implica un discorso sull’identità, mentre ogni azione a livello della base richiede di andare oltre all’idea di identità.
Ovvero, porre il problema del consumo come una questione di identità (come fanno indifferentemente le logiche del branding e molti gruppi di opposizione di vario tipo), al massimo permette di riconoscere la posizione del consumatore e il suo potere all’interno del sistema, ma allo stesso tempo lo priva di ogni potere reale sul sistema.

Allora cosa c’entrano i pappagalli?
Loro, niente. Quello che c’entra è la dialettica, nel senso tutto particolare che le dava Eisenstein all’interno della creazione artistica. La dialettica che è quel processo dinamico e paradossale che ci permette di essere pappagalli e uomini allo stesso tempo e attraverso cui possiamo percepire e, dunque, superare, i legami e le barriere che si impongono al nostro pensiero e alla nostra esperienza sociale per indirizzarli verso il cambiamento.
Carlo
Posted: February 20th, 2011 | Author: anarcosurr | Filed under: La chambre d'écoute | Comments Off on Ramen 5
 Leaky World il gioco de la molleindustria su Wiki Leaks, ma soprattutto la loro prefazione critica, subito sotto. Per una contestualizzazione italiana, un articolo di Luca Valada da Carmilla, “Wikileaks e l’Italietta“.
Leaky World il gioco de la molleindustria su Wiki Leaks, ma soprattutto la loro prefazione critica, subito sotto. Per una contestualizzazione italiana, un articolo di Luca Valada da Carmilla, “Wikileaks e l’Italietta“.
La storia della lettura dell’Ulisse di Joyce per LibriVox, un sito che produce e condivide audiolibri, About that Ulysses Recording.
Punti di vista Peruviani sul significato e l’efficacia dell’anarchia, dall’Archivio Anarquista Peruano, Desobediencia Anarquia y Realidad.
My bad, l’ho scoperto da poco, ma Screen, storica rivista di teoria del cinema, è disponibile integralmente online. Fate un giro intorno agli anni settanta-ottanta.
Carlo
Posted: January 21st, 2011 | Author: anarcosurr | Filed under: La Sortie de l'école | Comments Off on Utopia dell’educazione

Come un nonluogo consiste in un luogo privo di relazioni sociali, il nontempo è un tempo privo di storia. E’ l’idea di tempo caratteristica di quello che in passato si sarebbe chiamato un ordine cosmico immutabile, e che oggi è l’ordine globale.
L’idea di nontempo implica prima di tutto che il presente non possa cambiare. In questo senso il nontempo, come tempo privo di dialettica, è il risultato di quella che Fukuyama chiama fine della storia: l’impossibilità (materiale o solo ideologica) di andare oltre al sistema democratico e liberista.
Che interesse ha, in sé, il concetto di tempo all’interno dell’ordine globale? Onestamente, non molto. Anche per questo l’ultimo libro di Marc Augé sembra avere un titolo tirato per i capelli: Où est passé l’avenir?
Sono più interessanti alcune considerazioni su argomenti vari, legati più all’idea di cultura come natura (70) che al concetto di nontempo: la globalizzazione come sistema ideologico, il senso e la contestazione nella società, nell’arte e nella critica della cultura, e quella che Augé chiama l’utopia dell’educazione.
Augé parla della globalizzazione come di una “ideologia della globalità senza frontiere”, che produce allo stesso tempo uniformità ed esclusione (33).
In forza della sua egemonia ideologica il globale è vissuto come interno, familiare, sensato, mentre il locale è considerato esterno al sistema, deviante. Per lo stesso motivo, il locale è l’unica possibile fonte di contestazione e anche di “storia”, che Augé tratta come sinonimi (35).
E’ anche evidente, però, che ogni comunità locale ha bisogno di negoziare un accesso al sistema globale per poter esercitare la propria influenza, in certi casi, per negoziare la propria stessa esistenza. Ma nel momento in cui una comunità locale(se si vuole, una sub-cultura) accede ai media accede necessariamente anche alle ideologie che gli danno forma.
Ed è, io credo, questo rapporto di dipendenza dei gruppi locali verso le strutture globali di comunicazione che costituisce l’imporsi stesso del sistema e che determina l’ambiguità di quelle forme di contestazione, politica, intellettuale ed artistica, che spesso rimangono, secondo Augé, “prigioniere di quegli stessi schemi di pensiero alle quali si oppongono” (12).
I media diventano quindi la scena in cui avviene lo scontro tra conformismo e contestazione. Più ancora, i media possono essere identificati con il sistema stesso, in quanto codificano il rapporto tra società e individuo: “[…] i media svolgono oggi il ruolo che un tempo spettava alle cosmologie, alle visioni del mondo che sono allo stesso tempo visioni della persona e che creano un’apparenza di senso legando strettamente i due punti di vista. […] L’indispensabile necessità di dare senso all’universo, che Lévi-Strauss lega all’apparizione del linguaggio, si è attuata con l’imposizione sulla realtà del mondo di una logica simbolica applicata anche alle relazioni tra gli umani” (40).
In altre parole, abbiamo bisogno di ideologie – di sistemi di pensiero – per dare senso alle nostre esperienze, ma nella misura in cui l’ideologia determina a priori il senso delle nostre esperienze, riconducendole ad un universo di convenzioni, essa è anche il limite fondamentale all’espressione libera del pensiero di ogni individuo e il primo strumento del controllo sociale. In un modo simile Augé pone il “senso”, in quanto significato codificato da una cosmologia dominante, essenzialmente contro la storia, la creatività, la libertà e la scienza.
I media sono, in questi termini, un sistema di “senso”, un “mondo dell’immanenza nel quale l’immagine rimanda all’immagine e il messaggio al messaggio; mondo da consumare subito, come i bignè alla crema [come i fulmini, éclairs]; mondo da consumare ma non da pensare; mondo dove si possono attivare procedure di assistenza ma dove non è possibile elaborare strategie di cambiamento” (28). Sono l’applicazione del modello di consumo ai discorsi e alle relazioni sociali.
Allo stesso modo, anche nell’arte il sistema globale si impone come sistema di “senso”: nelle parole di Augé, “il primato del codice, che prescrive i comportamenti [… e] costruisce le relazioni, ha effetti pesanti sulle condizioni della creazione. Il mondo che circonda l’artista e l’epoca in cui vive gli si palesano solo in forme mediatizzate – in immagini, avvenimenti, messaggi – che sono esse stesse effetti, aspetti e motori del sistema globale” (49-50). Col risultato che l’arte, invece di distruggere le evidenze della cultura in cui prende forma si riduce ad una mera espressione del suo contesto. La massima aspirazione per l’opera d’arte diventa così acquisire “pertinenza” al suo contesto politico e sociale invece di ambire ad una “presenza” come forza di destabilizzazione (52).
L’arte propriamente detta prende quindi le distanze dal contesto, si oppone al senso, comune e non comune, e si distacca dagli apparati materiali che ne condizionano la produzione, così come da quelli ideologici che ne influenzano le forme e, molto spesso, ne determinano i contenuti.
In ultima analisi, il livello di azione più profondo del sistema globale rimane quello dei rapporti tra l’individuo e la comunità, già affrontato da Augé nella costruzione del concetto di nonluogo: “l’identità individuale non è definibile, pensabile e vivibile se non in relazione con altri. Ma anche il senso sociale a sua volta si smarrisce se l’individuo si dissolve nel conformismo, nell’omogeneità, nell’allineamento. L’individualità si realizza dunque nella solidarietà, ma noi sappiamo anche che questa realizzazione, nelle sue forme più alte (l’amore, l’amicizia) non ha bisogno di un quadro istituzionale. La forma sociale ottimale (che concilierebbe senso e libertà) sarebbe allora quella che consentirebbe a tutti gli individui di realizzarsi liberamente senza isolarsi” (103-104).
Questa forma sociale, che Augé cautamente non nomina, è l’anarchia.
E per l’attuazione di questa forma sociale, che richiede il coraggio di ogni individuo di confrontarsi con la propria libertà (104), il primo passo sta in quella che Augé chiama “utopia dell’educazione”. Un progetto che deve ridistribuire la conoscenza come presupposto della giustizia sociale e come essenza del progresso sociale.
Una utopia, l’unica, che può essere “riformista nel metodo”, in quanto “ogni iniziativa puntuale, locale, può essere considerata come un passo nella giusta direzione, non come un tradimento dell’ideale” e perché, in merito all’educazione, nessun risultato è trascurabile (108). Il sapere, infatti, è l’opposto dell’ideologia, perché non è mai totalizzante, mai immobile, sempre nutrito dalle relazioni umane.
La rivoluzione sociale dipende dunque in prima istanza da una rivoluzione sociale dell’insegnamento.
Carlo
Marc Augé (2010) Che fine ha fatto il futuro?: Dai nonluoghi al nontempo. Milano: Elèuthera.
Conclusione sull’utopia dell’educazione.
Posted: December 3rd, 2010 | Author: anarcosurr | Filed under: La Sortie de l'école | Comments Off on From wonderland to non-place

Un non-luogo è definito da Augé come un luogo (fisico e mentale) privo della sua dimensione sociale. Non tanto una piazza vuota, quanto una piazza dove nessuno si parla.
Un aeroporto è un non-luogo, come lo sono l’interno di un’automobile, un’autostrada, o Disneyland. Facebook è, per certi versi, un non luogo. Ogni non-luogo è lieto di offrire a tutti conformità, consumo e un caratteristico tocco neofascista.
Se è vero, come scrive Marcuse, che l’individuo può esistere solo in contrasto con la società in cui vive, in un conflitto essenziale con le norme e i valori stabiliti, i non-luoghi determinano l’opposto dell’individuo: l’uniformità, sanzionata da convenzioni più o meno repressive o ideologiche. Uniformità che è anche il contrario della libertà e dell’uguaglianza, perché per prima cosa nega l’autonomia: feed me master, tell me who I am.
Ma più ancora di questo, i non-luoghi si sottraggono come spazi di lotta. Mancando ogni possibilità di rapporto sociale, l’uomo in rivolta non può che attaccare se stesso.
The arrangement_opening sequence (Kazan, 1969).
Come al solito, mi viene da sottolineare quanto il prestigio di queste strutture sia radicato nella paura dell’autonomia, più che nella loro imposizione forzata. Ma al di là di questo i non luoghi hanno una precisa identità politica, sulla quale Augé scivola in silenzio.
Identità che invece viene colta e sfruttata in modo genial-demenziale nella campagna di subvertising di Micky Mouth, che arruola topolino nel tea party, lo fa sparare ai messicani alla frontiera e gli fa costruire un muro impenetrabile intorno al suo dominio incantato.
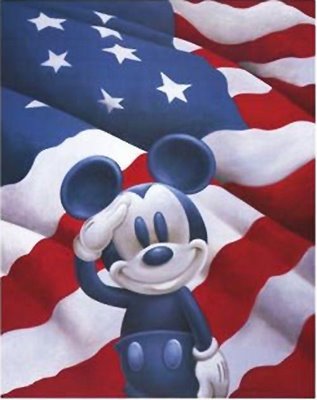
Non è una novità, topolino è sempre stato profondamente reazionario. Ma è una buona metafora, che coglie il livello infantile, e non per questo meno violento, del fascismo.
Disney è stato un pioniere dei non-luoghi. Ha attaccato il cuore della cultura popolare, le fiabe, e lo ha distrutto. Con il sostegno dell’intero apparato mediatico ha colonizzato un bene comune e lo ha trasformato in un bene di consumo e in uno strumento al servizio dell’ideologia dominante.

Togliendo dalle fiabe ogni vero conflitto, le ha private del loro significato profondo e contemporaneamente della loro dimensione sociale. In questo modo Disney ha distrutto un patrimonio fondamentale di narrazioni di lotta, di cui oggi si sente la mancanza.
Le sue creature non vivono in un mondo fantastico, ma in non-luoghi. Il loro non è un mondo surreale, perché non espone la realtà per coglierne gli aspetti nascosti, la loro non è una fantasia che si oppone alle convenzioni. E’ un mondo che nasconde la realtà e, quindi, la conferma.
E non c’è solo Disney, ovviamente. L’intera mainstream della letteratura e del cinema fantastico non è più in grado di proporre visioni del mondo surreali. Passato è anche il tempo di Blade runner e High rise (in lavorazione un film) in cui i non-luoghi erano l’oggetto della fantascienza, esaminati nelle loro dinamiche e nelle loro conseguenze. Se The road forse tiene (il film, fino a prima del finale), Children of men segna il momento in cui anche la distopia arriva a confermare le convenzioni.
Dopo l’Alice coloniale di Burton, la magia disincarnata di Harry Potter, l’addomesticamento fedele del Signore degli Anelli, l’inesistente Avatar, la valanga di animazioni pixar tutte giocate sui prototipi, Gian mi segnala che questo è il prossimo cappuccetto rosso:

Se l’acqua è un bene comune, lo sono anche le nostre storie.
Una storia non può essere raccontata più di una volta senza cambiarla, non è una proprietà, ma una creazione, cioè, fondamentalmente, una creazione condivisa. Persone, luoghi e racconti hanno bisogno gli uni degli altri. E qui torniamo alla definizione antropologica di società, che è il contrario del non-luogo.
Non possono esserci storie senza luoghi in cui poterle raccontare, ma i luoghi stessi, senza storie, non esistono.
Carlo
Posted: November 26th, 2010 | Author: anarcosurr | Filed under: La chambre d'écoute | Comments Off on Università: esproprio, non occupazione!
Viva le occupazioni! Viva le manifestazioni!
Però dobbiamo riconoscere che questo tipo di lotta (tra l’altro sempre più virato all’impatto mediatico che a quello sostanziale) ha senso, in un sistema democratico, solo se esiste una parte politica in grado di raccogliere e tradurre in legge la volontà delle piazze. Intendiamoci, questo non è un bene. Non lo è in generale. E non è un bene nello specifico, visto che di parti politiche in grado di raccogliere questa lotta senza comprometterla irrimediabilmente non ce ne sono.
Dunque, bene le manifestazioni perché fanno bene al tessuto sociale e aprono un po’ di orizzonte e di respiro. Ma se vogliamo evitare che tutto vada come sembra destino che vada, in Italia come all’estero, dovremmo cominciare a fare qualche scelta un po’ più radicale. Accontentiamoci di una battaglia per salvare il salvabile e l’unica cosa che otterremo è che tutto scivolerà più lentamente verso lo stesso risultato: privilegio e privatizzazione.
E’ verso questo sconvolgimento futuro che dobbiamo reagire. Dobbiamo anticiparlo. Cosa faremo quando questo scenario si sarà realizzato, quando non ci sarà neppure una università pubblica, quando solo pochi stronzi potranno permettersi di studiare? Lo stesso dobbiamo cominciare a farlo ora.
Non penso che la soluzione debba essere violenta, ma non penso nemmeno che possa essere istituzionale. Quello che dovremmo fare è una cosa titanica: rifare l’università da zero. Reinnestarla senza compromessi nella società, e questo vuol dire tenersi al di fuori delle strutture esistenti. Fisicamente, non solo intellettualmente. Sottrarla al controllo creando un sistema di creazione e condivisione del sapere che non possa essere rigidamente controllato, e che sia più giusto e più funzionale. Non tanto occupare l’università, ma espropriarla. Creare un sistema parallelo.
Se è vero che questo esproprio non è possibile perché mancano le condizioni sociali, perché non si può che avanzare passo dopo passo e che per ogni passo sospeso verso la rivoluzione, l’altro piede non può che poggiare nell’accettazione del sistema, e se è vero che non è possibile perché ci mancano la forza e la disperazione per saltare a piè pari, se è vero questo, è anche vero che senza una utopia davvero convincente non troveremo mai il coraggio per fare neanche un metro. Senza una utopia che regga, che vada oltre l’ideologia e l’anticonformismo conformista, quindi senza un vero pensiero critico diffuso, possiamo pure dire ciao all’università.
Carlo
Posted: November 5th, 2010 | Author: anarcosurr | Filed under: La chambre d'écoute | Comments Off on Ramen 4

Da The Anarchist Library un articolo molto interessante sui limiti dell’attivismo come forma di cambiamento sociale: Give up Activism.
Link a un documentario di David Ridgen and Nicolas Rossier su Norman Finkelstein, professore americano e fierissimo contestatore dell’occupazione in Palestina: American Radical: The Trials of Norman Finkelstein.
Finkelstein (2000) The Holocaust Industry: .pdf inglese, .pdf italiano.
Subvertising e culture jamming: i siti di Adbusters e di RTMark. E un articolo buono per un po’ di background sull’argomento: Viral activism and the meaning of post-identity.
Fuori tema, un corto di Tomek Baginski: Fallen art.
Carlo